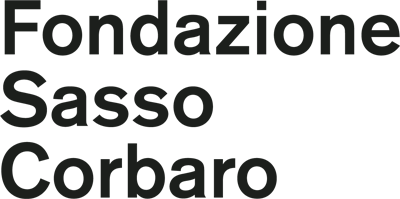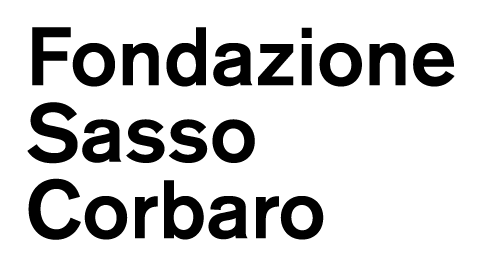Libri
Consigli di lettura, spunti di riflessione, recensioni di libri raccolti nel Centro di documentazione della Fondazione Sasso Corbaro.
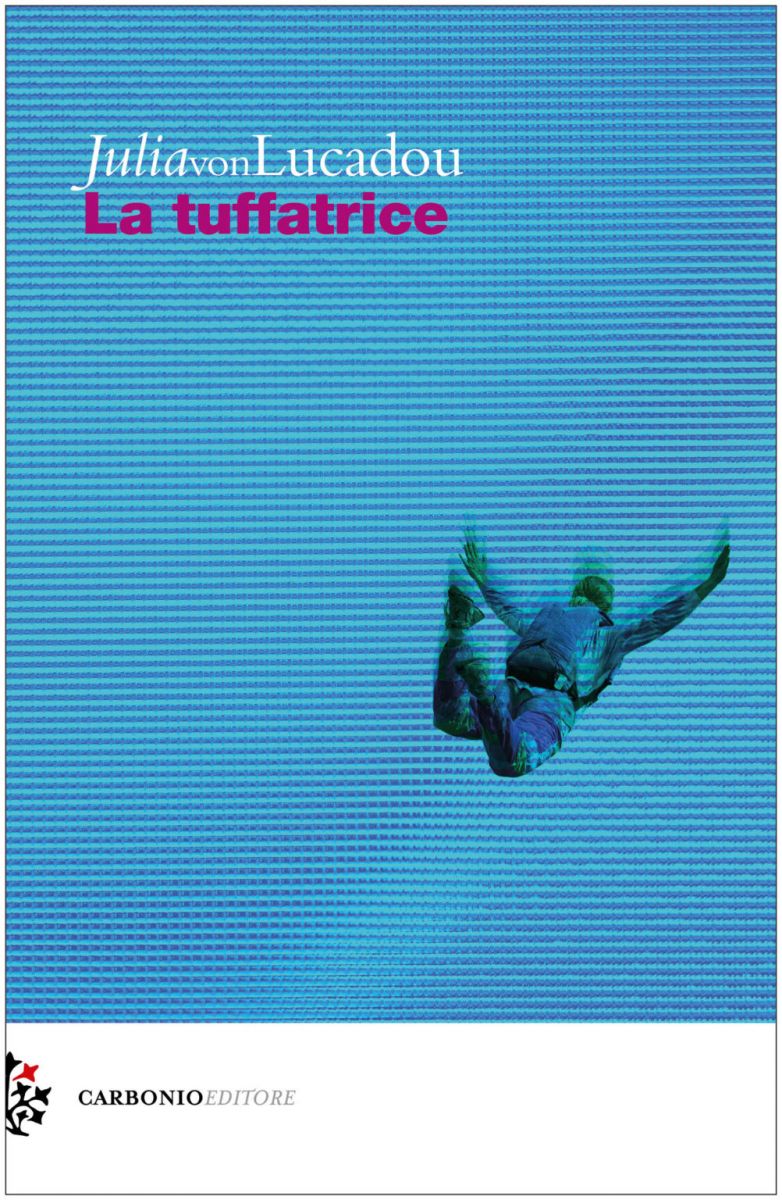 La tuffatrice
La tuffatriceJulia Von Lucandou
Carbonio, Milano, 2020.Vincitore dello Schweizer Literaturpreis nel 2019, La tuffatrice è il romanzo d’esordio della scrittrice tedesca classe ’82, Julia Von Lucadou.
Si tratta di una distopia orwelliana, ambientata in un futuro ...Vincitore dello Schweizer Literaturpreis nel 2019, La tuffatrice è il romanzo d’esordio della scrittrice tedesca classe ’82, Julia Von Lucadou.
Si tratta di una distopia orwelliana, ambientata in un futuro dietro l’angolo, nella quale la psicologa del lavoro Hitomi Yoshida, protagonista delle vicende, viene ingaggiata per riabilitare la star del tuffo dai grattacieli Riva Karnovski, che, a causa di un grave burn-out, ha abbandonato gli allenamenti e le competizioni.
Romanzo dal ritmo e dalle atmosfere cinematografiche (leggete qui il primo capitolo che è un vero e proprio capolavoro in tal senso!), per il quale la scrittrice ha attinto dai suoi studi nel campo della settima arte e dal suo lavoro di sceneggiatrice, questo La tuffatrice è ricchissimo di spunti tematici interessanti. Spicca l’analisi della metropoli ipertecnologica, divisa tra centro ricco e periferia degradata, in cui si muovono i vari personaggi, che, oltre alle due donne, sono uno spietato datore di lavoro, un blogger di successo e un fotografo alla ricerca dell’affermazione.
La Von Lucadou, nonostante sia alla prima prova con questa forma, è perfettamente a suo agio quando crea e descrive in maniera dettagliata un universo urbano alienante e brutale, in cui tutti sono spiati da telecamere (compreso, a sua insaputa, la paziente Riva Karnovski), le prestazioni e le abitudini personali vengono monitorate e valutate dai superiori ventiquattro ore al giorno e le relazioni di coppia sono il frutto di una corrispondenza di caratteristiche individuali messa in atto da algoritmi informatici.
Senza dubbio, la carne al fuoco in questo libro è molta, ma, grazie anche ad uno stile di scrittura fresco e godibile e al continuo stimolo che il lettore riceve dai non detti e dagli spunti di trama volutamente non approfonditi, al termine della lettura se ne vorrebbe ancora di più.Perché leggerlo? Perché, per certi aspetti, il futuro di questo romanzo… è già il nostro presente!
Una citazione dal libro: «“Non riesco a immaginare” dice Zarnee dopo un po’, “come possa essere tuffarsi da un grattacielo. Non ho mai osato farlo”.
“È difficile da descrivere” dice Riva. “Sei presente a te stesso al cento per cento, il resto del mondo non conta. E allo stesso tempo sei fuori di te, in preda all’adrenalina. È una sensazione bellissima. Hai tutto, e in un secondo puoi perderlo. È come essere innamorati”».Recensione di Federica Merlo
Agosto 2021
ChiudiLeggi la recensione
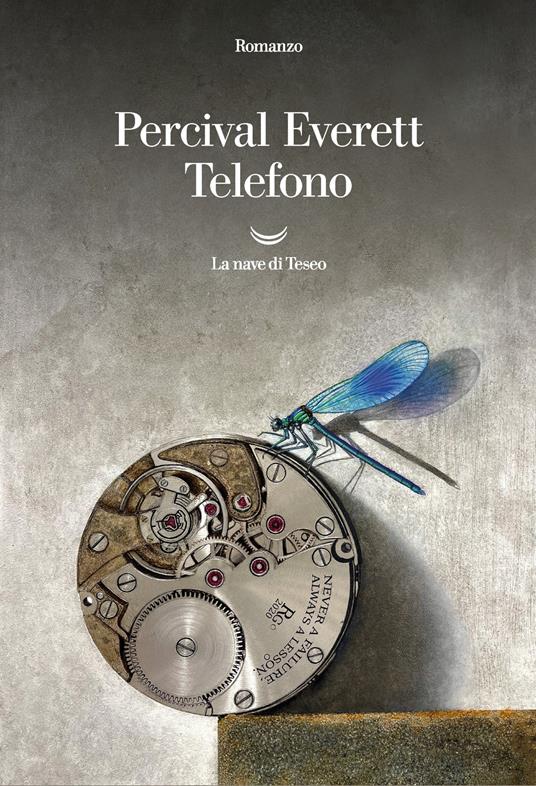 Telefono
TelefonoPercival Everett
La nave di Teseo, Milano, 2021Ci sono autori che vorresti leggere da un po’, ma non si sa perché, restano lì. Poi, quando ti decidi, è difficile scegliere da dove iniziare: si va in ordine di ...
Ci sono autori che vorresti leggere da un po’, ma non si sa perché, restano lì. Poi, quando ti decidi, è difficile scegliere da dove iniziare: si va in ordine di pubblicazione? Ci si butta subito sul libro migliore?
Anche con Percival Everett, scrittore statunitense classe ’56, noto per essere l’afroamericano che non parla degli afroamericani, mi è successo così. Finché a luglio di quest’anno i tipi de La Nave di Teseo non hanno pubblicato Telefono, ultima fatica di Everett con la quale è arrivato in finale al Pulitzer 2021 (vinto da Louise Erdrich con «The Night Watchman», che sarà tradotto da Feltrinelli e arriverà in autunno).
Questo Telefono è un romanzo «di sentieri che si biforcano», come recita la quarta di copertina, nel quale il protagonista Zack Wells, professore di geologia losangelino e prototipo di quell’americano realizzato al quale apparentemente non dovrebbe mancare nulla, viene sconquassato dai drammi che la vita gli riserva. La grandezza del romanzo, al di là dell’interesse che possano suscitare le molte vicende (e i molti plot twist) che con l’andare delle pagine si accumulano l’una sull’altra senza mai veramente concludersi, sta nel brillante talento letterario di Everett, capace di tenere tutto insieme senza mai disorientare o annoiare il lettore. Per concludere, penso che ancora tre cose meritino di essere menzionate di Telefono. La prima è il personaggio Zack Wells, narratore in prima persona della vicenda, che per me è tra i più profondi e memorabili scritti ultimamente. La seconda è la bravura di Everett nel descrivere il percorso di sofferenza affrontato da Wells e dalla moglie Meg quando alla figlia Sarah viene diagnosticata una gravissima malattia. La terza è che il romanzo ha tre finali e comprandone una copia il lettore potrà leggerne soltanto uno. So che questa trovata farà arrabbiare molti, ma a me ha intrigato parecchio.Perché leggerlo? Perché, come dice l’amico e bookblogger Angelo Cennamo su Telegraph Avenue (trovate qui la sua recensione di Telefono) «Leggere Percival Everett è come saltare nel buio: occorre fidarsi, lasciarsi condurre senza fare tante domande».
Una citazione dal libro: «Il modo in cui ci trattiamo a vicenda cambia a un ritmo che in tutte le altre aree dell’esperienza umana ci risulterebbe intollerabile. Potremmo definire tale ritmo lento, rilassato o, più correttamente, glaciale. Un ghiacciaio è una massa di ghiaccio e firn, neve compatta, che mostra segni di movimento, creatasi dove la produzione di neve è superiore all’ablazione e così perdurante da un anno all’altro, persistendo anche quando un cambiamento nel clima annulla le condizioni che le hanno consentito di esistere. Lo stesso accade con le oscenità, le offese e il dolore che ci infliggiamo a vicenda, con il pregiudizio, la negligenza, la tortura e la schiavitù. Come i ghiacciai, queste cose non sono confinate in un’unica parte della terra».
Recensione di Federica Merlo
Agosto 2021
ChiudiLeggi la recensione
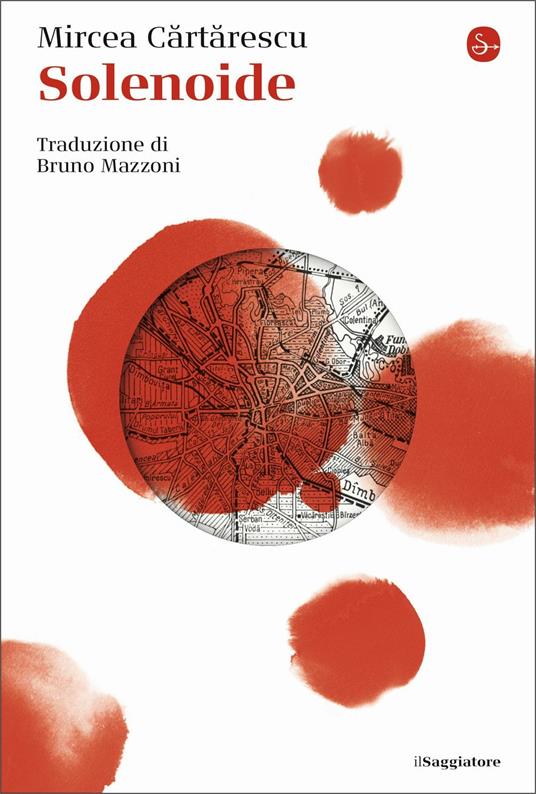 Solenoide
SolenoideMircea Cartarescu
Il Saggiatore, Milano, 2021Dopo Yoga di Emmanuel Carrère, recensito il mese scorso, un altro dei libri più attesi di questo 2021 era sicuramente Solenoide, ultima impresa letteraria dell’autore ...
Dopo Yoga di Emmanuel Carrère, recensito il mese scorso, un altro dei libri più attesi di questo 2021 era sicuramente Solenoide, ultima impresa letteraria dell’autore rumeno Mircea Cartarescu, uscito a maggio per Il Saggiatore con la curatissima traduzione di Bruno Mazzoni.
Cartarescu, che da tempo si vocifera possa essere uno dei prossimi premi Nobel, dopo aver scritto una meravigliosa trilogia quale è Abbacinante (3 volumi di più di 500 pagine ciascuno) «si è superato» (Vanni Santoni su La lettura).
Solenoide è infatti un testo (lo stesso autore non vorrebbe lo si definisse romanzo) mastodontico di 937 pagine che evade da qualsiasi definizione si tenti di attribuirgli (un po’ autobiografia, un po’ fiction, un po’ racconto di fantascienza). Volendo ridurre all’osso la trama, nel libro si parla della vita di un giovane scrittore fallito che finisce col diventare un anonimo professore di una scuola periferica di Bucarest, città apocalittica e alla deriva, sotto il regime di Ceaușescu. Tuttavia, come spesso accade quando ci si trova di fronte ad opere di questo calibro, solo paragonabili ad altri capolavori massimalisti quali 2666 di Bolaño, L’arcobaleno della gravità di Pynchon o al più recente Infinite Jest di Wallace, le vicende sono sovrastate, annichilite dalla prorompente potenza dello stile. Cartarescu sfrutta la sua prosa barocca e la sua straordinaria conoscenza di concetti e termini propri del mondo scientifico della matematica, della fisica, della medicina e della biologia per dimostrare in ogni pagina «la forza esorbitante della letteratura» (Vanni Santoni su La lettura). Se però il rischio potrebbe essere quello di pensare che Solenoide sia solo una pura dimostrazione stilistica, l’estetica di un grande virtuoso della penna fine a se stessa, ci si rende presto conto che le molteplici dimensioni proposte dallo scrittore rumeno, siano esse fisiche, metafisiche, oniriche o allucinatorie, non sono affatto dei giochi letterari, bensì veri e propri tentativi «di farsi carico dei problemi dell’umanità» (Cartarescu intervistato da Vanni Santoni sulla pagina Facebook de Il Saggiatore).
Non stupisce quindi che siano la realizzazione, le sconfitte, le relazioni sociali, amorose e familiari e il confine tra la vita e la morte la vera materia pulsante con la quale il lettore è costantemente chiamato a confrontarsi fino a rimanerne, per usare un termine caro allo scrittore, abbacinato.Perché leggerlo? Perché questo è uno dei migliori libri degli ultimi vent’anni (e anche la critica, per una volta, è unanime). E poi perché vi sfido a trovare una città letteraria meglio descritta della Baucarest di Carteruscu… una metropoli a dir poco folle!
Una citazione dal libro: «Nessun romanzo ha mai mostrato una strada da seguire, ma assolutamente tutto viene riassorbito nell’inutile nulla della letteratura. Il mondo si è riempito di milioni di romanzi che eludono l’unica ragione di essere che la scrittura abbia mai avuto: quella di comprendere te stesso fino in fondo, fin nell’unica stanza del labirinto della mente in cui non hai diritto di penetrare».
Federica Merlo
ChiudiLeggi la recensione
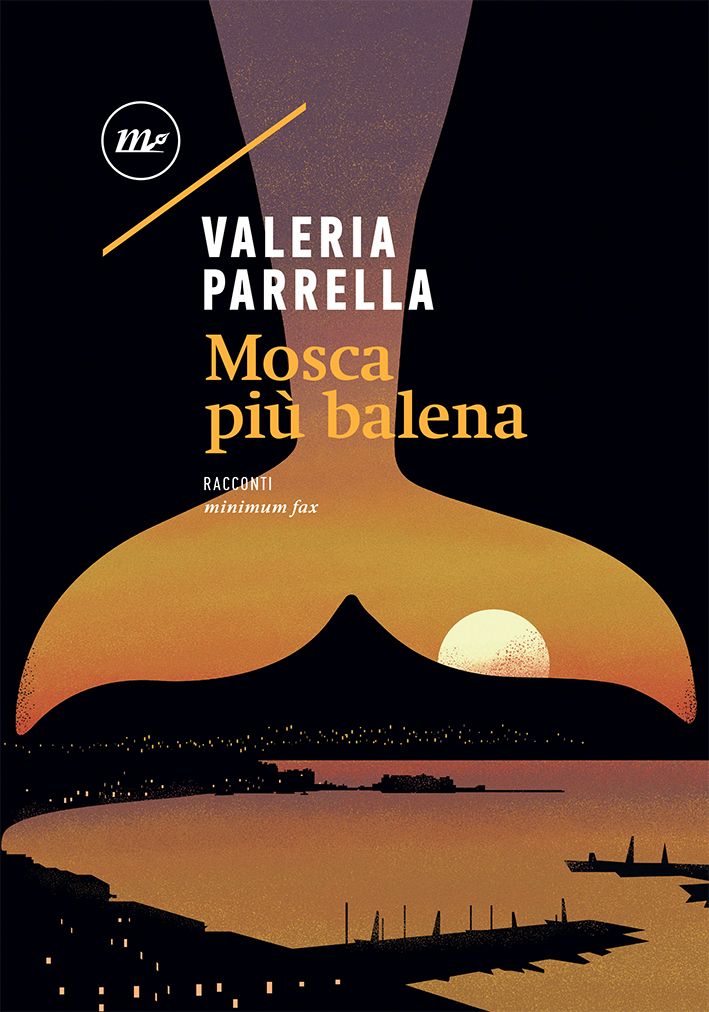 Mosca più balena
Mosca più balenaValeria Parrella
Minimum Fax, Roma, 2021Appena riedita da Minimum Fax, che pubblicò anche la prima edizione nel 2003, Mosca più balena è la raccolta di sei racconti con la quale ha esordito e si è fatta ...
Appena riedita da Minimum Fax, che pubblicò anche la prima edizione nel 2003, Mosca più balena è la raccolta di sei racconti con la quale ha esordito e si è fatta conoscere al grande pubblico dei lettori Valeria Parrella, una delle penne migliori nell’attuale panorama letterario italiano.
Mosca più balena, con la quale l’autrice ha vinto il Premio Campiello opera prima e il premio Amelia Rosselli, è composta da sei racconti (a mio avviso primo, secondo e sesto spiccano sugli altri) accomunati dall’avere tutti come protagoniste delle donne. Contraddizioni, disparità sociali, rapporti complicati e i piccoli-grandi problemi da affrontare nel quotidiano di una Napoli vitale, chiassosa, colorata ma anche difficile e ambigua, sono il microcosmo nel quale, con una scrittura già precisa e pungente, Parrella costruisce e fa muovere, con stupefancente capacità narrativa, i suoi personaggi. Ci si diverte parecchio a leggere questo Mosca più balena (che ha forse come unico difetto quello di essere troppo breve) e soprattutto si trovano costantemente spunti per profonde riflessioni di carattere antropologico… e allora, ancora una volta, grazie alla buona letteratura!Perché leggerlo? Per scovare i germogli letterari che, sbocciati negli anni a venire, hanno reso Parrella l’ottima scrittrice di romanzi quali Lo spazio bianco e Almarina, per citarne soltanto due. E perché comprandovi una copia fisica di questo libro, diventerete proprietari di una delle copertine graficamente più belle e azzeccate mai create.
Una citazione dal libro: «Le ragazze dicevano che dovevo leggere molto, una matricola mi prestò dei best seller e il primo fu quello della Tamaro. Mi sembrò un libro impossibile: se io fossi andata dove mi portava il cuore, sarei rimasta incinta a tredici anni nell’Ape di Totonno il pezzaro».
Federica Merlo
ChiudiLeggi la recensione
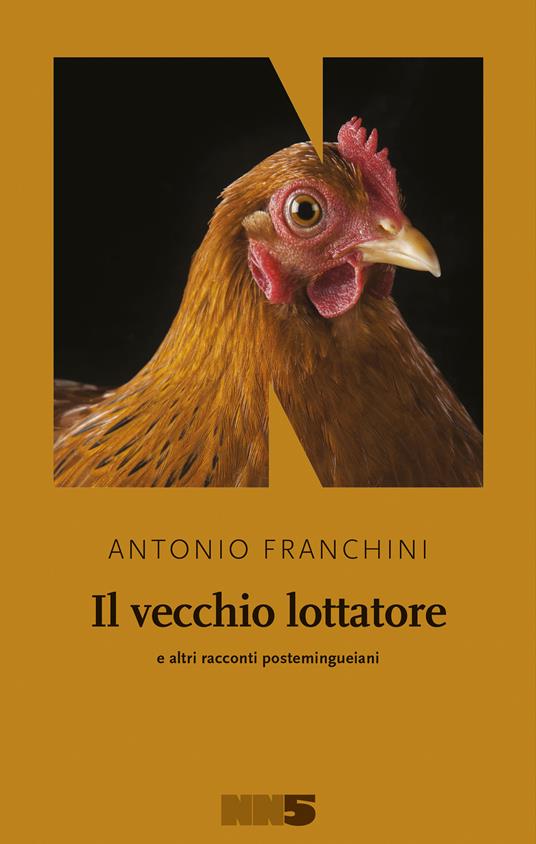 Il vecchio lottatore
Il vecchio lottatoreAntonio Franchini
NN Editore, Milano, 2020«A Nicolò, da Antonio». Mi piace iniziare questa recensione con la dedica che l’autore (Antonio Franchini oltre ad essere uno scrittore è anche uno dei più famosi editor ...
«A Nicolò, da Antonio». Mi piace iniziare questa recensione con la dedica che l’autore (Antonio Franchini oltre ad essere uno scrittore è anche uno dei più famosi editor italiani) ha scritto sulla mia copia de Il vecchio lottatore. Faccio questo perché ho la convinzione che chi ami, come me, la letteratura, goda anche, ogni tanto, dei suoi momenti partecipativi, quelli in cui ci si siede su seggioline precarie con altri appassionati e si ascolta lo scrittore che racconta il «dietro le quinte» del romanzo, il perché di alcune scelte, da cosa ha tratto ispirazione, il suo modo di lavorare etc. Questo è accaduto – nel mio caso dopo più di un anno – il 5 maggio scorso al teatro Foce di Lugano, dove Franchini è stato ospite di «Agorateca Incontri» per parlare, con un altro scrittore, Luca Saltini, del suo ultimo libro, edito dai tipi di NN (potete recuperare l’incontro integrale qui).
Il Vecchio lottatore è una raccolta di nove racconti, che, come dice il bel sottotitolo «e altri racconti postemingueiani», sono tutti legati dall’ambizioso filo rosso Hem. Questo, non tanto per lo stile di scrittura, qui distante dal minimalismo del Nobel americano, ma per i temi. Ci sono, infatti, la pesca, la guerra, lo sport, le amicizie, i personaggi del quotidiano che diventano mitici e, come chiosa emblematica di un modo di affrontare la vita, nell’ultimo racconto c’è la lotta.
Qualità elevatissima della prosa, straordinaria capacità di attualizzare argomenti cari a una narrativa che ha molto contribuito a plasmare gli scrittori della generazione di Franchini (che è un classe ’58) e introspezione psicologica dei personaggi, caratterizzati con grande sapienza nel breve spazio concesso dal racconto, rendono questo libro una delle proposte più interessanti tra le recenti uscite della narrativa in lingua italiana.Perché leggerlo? Perché Franchini, con coraggio, affronta argomenti che all’interno del dibattito delle idee di questi ultimi anni partirebbero perdenti, rendendoli invece pieni di senso e assolutamente attuali.
Una citazione dal libro: «La vita dei sentimenti è confusa, si soffre per ragioni futili e sbagliate, si procura dolore agli altri senza volerlo e gioie senza esserne consapevoli, il bene e il male hanno contorni incerti e la coscienza li rimugina all’infinito in monotoni soliloqui, quando si è svegli, e in oscure visioni cercando il sonno che non arriva, ma quel giorno su Balmuccia lui aveva individuato il gesto perfetto».
Nicolò Saverio Centemero
ChiudiLeggi la recensione
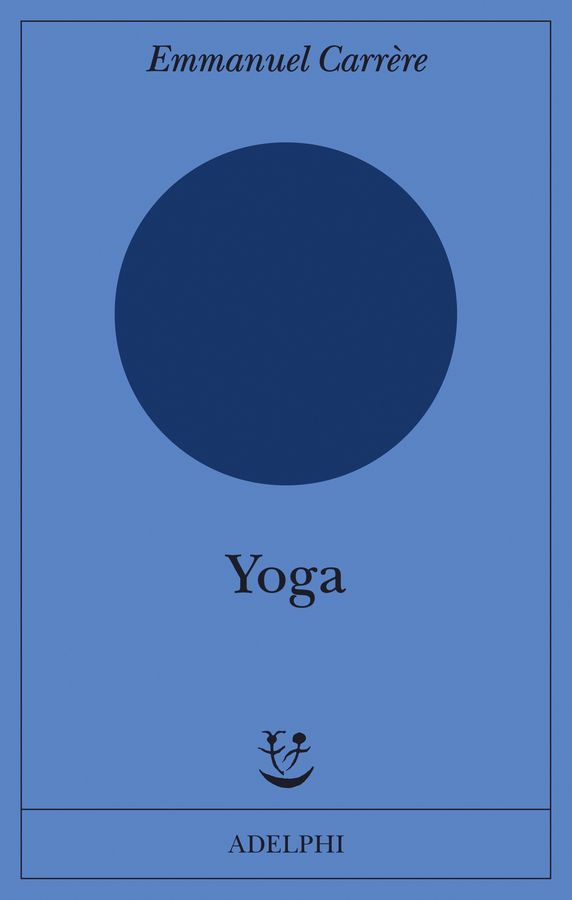 Yoga
YogaEmmanuel Carrère
Adelphi, Milano, 2021Partiamo da un dato di fatto: Yoga, ultimo libro dello scrittore Emmanuel Carrère (in Francia pubblicato ...Partiamo da un dato di fatto: Yoga, ultimo libro dello scrittore Emmanuel Carrère (in Francia pubblicato l’autunno scorso), era l’uscita di narrativa in traduzione più attesa del 2021. Come spesso accade (e con Carrère potremmo sostituire lo spesso col sempre) quando l’aspettativa è così elevata, il rischio è quello che ci si divida tra chi lo legge ed è «l’ennesimo indiscusso capolavoro» e chi invece trova che il testo abbia tradito le aspettative. Io devo confessare che, se proprio mi dovessi schierare, starei di sicuro coi i primi. Proverò qui di seguito a darvi le mie personali motivazioni, sperando possano scatenare in voi l’interesse per un libro… semplicemente bellismo!Per prima cosa, Yoga aggiunge un ulteriore tassello a quel percorso che lo scrittore francese sta compiendo ormai da trent’anni all’interno della sua produzione. Partito come romanziere puro (si legga Baffi), Carrère è approdato all’autofiction – genere che ha indubbiamente contributo a rinnovare (si legga Vite che non sono la mia) – mettendo al centro della narrazione non tanto se stesso, quanto più le persone che ha incontrato o ha voluto incontrare (si leggano L’Avversario e Limonov) nella sua vita. Con Yoga però il passo è ancora ulteriore (che bello quando uno scrittore non si stanca di cambiare in continuazione!) ed il protagonista diventa solo lui, o forse sarebbe meglio dire, il personaggio Carrère. La passione per la meditazione, le due perdite di amici importanti, il disturbo bipolare di cui soffre, l’esperienza nell’hot spot per migranti dell’isola Greca di Leros sono descritte nel libro fornendo al lettore gli aspetti più intimi, profondi e contradditori del personaggio Carrère.
Seconda cosa, la qualità della scrittura è altissima e, se questo non stupisce, è il solito Carrère insomma, tuttavia, ancora una volta è stato capace di trovare una novità anche a livello stilistico. Infatti, se nei testi precedenti i capitoli erano piuttosto lunghi, in Yoga, lo stesso autore in alcune interviste confessa di essersi divertito molto ad accorciarli e cercare per ciascuno un titolo molto peculiare. Dal mio punto di vista questa operazione è riuscita alla perfezione e dà alla narrazione un ritmo incalzante, che spesso vivifica quelle che potevano diventare le parti più lente e noiose (le descrizioni di alcune sedute meditative di gruppo, per esempio).
Terzo, la totale assenza di retorica e quel gusto per la provocazione (non entro nel merito e vi lascio scoprire qualche retroscena polemico legato all’ex-moglie o a quanto ci sia di vero o di inventato nelle vicende narrate) che lo rendono, come già è stato per tanti altri suoi libri, argomento di continuo dibattito tra i suoi tanti abituali lettori e non solo. E questo, a mio modesto parere, fa benissimo alla letteratura…Perché leggerlo? Perché troverete tanto della società degli ultimi anni (la crisi dei migranti, la malattia mentale, l’introduzione, a volte in maniera un po’ superficiale, delle filosofie di origine orientale, l’attentato a Charlie Hebdo) raccontato in maniera mai banale, spesso provocatoria, e a volte persino eccessiva, ma proprio per questo, molto vera.
Una citazione dal libro: «Io, che aspiravo all’unità, sono sceso a patti con la divisione. Quanto al tracollo di cui parlo, che cosa posso dirne? Che cosa devo tacerne? Quando penso alla letteratura, al genere di letteratura che faccio, di una sola cosa sono fermamente convinto: è il luogo in cui non si mente. È un imperativo assoluto, tutto il resto è secondario, e a questo imperativo penso di essermi sempre attenuto. Le cose che scrivo forse sono narcisistiche e vane, ma non sono false».
Federica Merlo
ChiudiLeggi la recensione
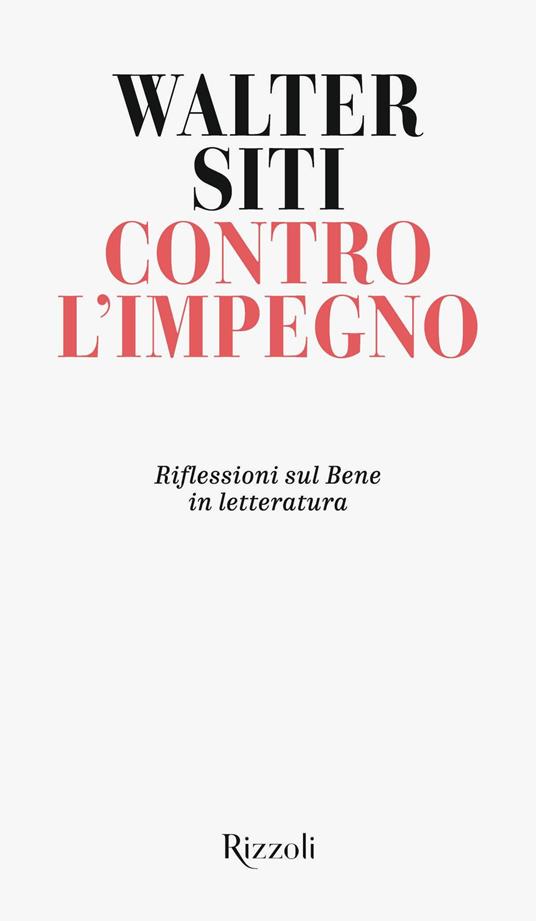 Contro l’impegno
Contro l’impegnoWalter Siti
Rizzoli, Milano, 2021Il 27 aprile è stata pubblicata una nuova raccolta di saggi, qualcuno inedito e qualcuno già uscito su giornali e riviste «seppure qui arricchito e risistemato per la nuova collocazione» ...
Il 27 aprile è stata pubblicata una nuova raccolta di saggi, qualcuno inedito e qualcuno già uscito su giornali e riviste «seppure qui arricchito e risistemato per la nuova collocazione» di Walter Siti. Tanto è stato il desiderio di leggere subito il testo, considerata anche la tematica vicina agli argomenti d’interesse della Fondazione Sasso Corbaro, che l’ho subito preso in e-book e finito la sera successiva.
Il libro analizza in maniera critica uno dei temi fondanti della letteratura ancora oggi molto attuale, quello che Sartre definiva l’engagement. Siti contesta l’attuale deriva della letteratura che, «come una brava infermiera», deve per forza fare del bene risanando il maggior numero di lettori possibile. In passato – fin qui niente di nuovo – si è sempre chiesto alla letteratura di essere «morale» e la stragrande maggioranza dei classici lo dimostra. Il problema attuale però, secondo Siti, è che tutto questo impegno, tutti questi messaggi positivi, hanno relegato in secondo piano «semplificando ed esteriorizzando», la forma. Individuati i temi, «buoni per definizione» (migranti, vari tipi di diversità, malattie rare, orgoglio femminile, olocausto etc.), quello che importa è che il messaggio arrivi senza «deludere», «sconcertare» o «disgustare», il fido lettore.
La grandezza di questo Contro l’impegno, che dichiara tutto quanto ho riportato sin qui nella parte iniziale, sta anche nel fatto che, nella parte centrale, oltre a fare precisi riferimenti agli scrittori (tra gli altri Perrin, Murgia, Carofiglio, Saviano vengono «smontati» con la raffinatezza e le armi del critico letterario di razza) Siti fa anche molti esempi televisivi e legati ai nuovi media (podcast, social network etc.), anch’essi colpevoli di sacrificare la forma («strumento di conoscenza» e «contenuto a tutti gli effetti»), per far prevalere l’efficacia di un messaggio leggero, superficiale, frammentario, veloce… aereodinamico, per citare (come fa lo stesso Siti) il Baricco di The Game.
Nel capitolo finale, a mio avviso insieme ai primi il migliore di tutto il libro, lo scrittore si chiede se ci sia «un modo per la letteratura di sostenere cause etiche e/o politiche senza avvilire le sue potenzialità conoscitive?» e risponde con tre esempi che vi lascio scoprire (Spoiler: dei tre uno è attuale, uno è un classico e uno un classicissimo!).Perché leggerlo? Per imparare come si fa «critica» e quanto sia fondamentale essere competenti, preparati e studiare a fondo la materia di cui si scrive… per farla bene!
Una citazione dal libro: «Si fatica a distinguere tra l’uso benefico della parola quale si verifica in vari campi della cultura (psicanalisi, antropologia, educazione, giornalismo) e la letteratura che invece dovrebbe essere ascolto e avventura della parola».
Federica Merlo
ChiudiLeggi la recensione
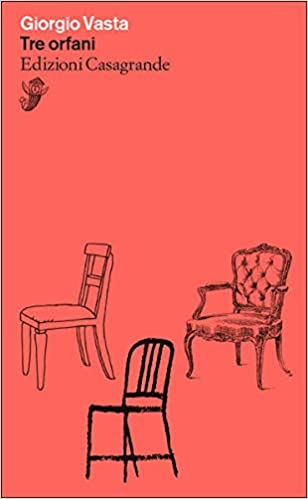 Tre orfani
Tre orfaniGiorgio Vasta
Casagrande, Bellinzona, 2021Tre diverse sedie campeggiano sulla bellissima copertina rosso vivo che l’editore Casagrande ha pensato per questo breve e fulminate racconto di Giorgio Vasta, scrittore (suoi i capolavori Il ...
Tre diverse sedie campeggiano sulla bellissima copertina rosso vivo che l’editore Casagrande ha pensato per questo breve e fulminate racconto di Giorgio Vasta, scrittore (suoi i capolavori Il tempo materiale e Absolutely Nothing), sceneggiatore (Via Castellana Bandiera e Le sorelle Macaluso di Emma Dante) e direttore editoriale di Book Pride (fiera nazionale italiana dell’editoria indipendente).
Tre orfani racconta dell’incontro di Vasta stesso, il giorno del suo cinquantesimo compleanno «alle sei del mattino di giovedì 12 marzo 2020» con i due personaggi «melvilliani» Achab e Bartleby, nella cucina della sua casa di Palermo. Reclusi per ragioni sanitarie in questo spazio domestico che percepiamo soltano come qualcosa di minimale ed essenziale, i suoi concreti fantasmi letterari fanno cose: preparano una torta «amalgama di formaggio e biscotti allo zenzero», guardano i bollettini della protezione civile su youtube, cancellano conversazioni di WhatsApp (Bartleby), intagliano un manico di scopa (Achab) le cui schegge diventano candeline per il dolce del compleanno. Ad un certo punto la scena si sposta in un esterno, sempre di reclusione: un terrazzino dal quale, come sul ponte della baleniera, Palermo si trasforma nell’Atlantico («Atlantica» è stato il titolo del festival letterario Babel del 2020 per il quale Vasta ha scritto il racconto), Palermo è la balena, Palermo è anche New York… e «l’unica cosa certa» restano i «tre orfani misantropi che sotto un cielo dove adesso gridavano le procellarie stavano finalmente per mangiare un tortino di formaggio, zenzero, acqua e fuoco».
Onirico, perturbante, straniante, visionario, malinconico, nostalgico, etereo, fluttuante, profondo, cupo… è quasi impossibile smettere di trovare aggettivi per descrivere quanto si percepisce dalle parole di Vasta che, non solo sono capaci di evocare tempi e spazi, ma anche sonorità (si legga per esempio, ad alta voce, questa frase: «ma sulle cementine, e soprattutto sulle parti pavimentate col parquet, avevo contemplato un succedersi di piccoli solchi, a volte curvi e in altri punti sgorbiati – il riflesso geroglifico di un turbamento»).Perché leggerlo? Non solo perché se doveste scegliere un solo libro uscito quest’anno per ora vi direi di leggere assolutamente questo, ma anche perché a pensarla come me è anche il poeta Gianni Montieri che scrive sulla rivista culturale on-line Minima & moralia: «Il libro consta di trenta pagine e ne ha la densità di mille» e «Vasta fa letteratura, tutto qui. Io trovo conforto in tutto questo». Per chi volesse ascoltare Montieri e Vasta sulla pagina Facebook di Edizioni Casagrande trovate anche la loro video-intervista.
Una citazione dal libro: «Di colpo malinconico, aveva chinato il capo, si era voltato, aveva preso una sedia e si era sistemato accanto a Bartleby. Non per un desiderio preciso, ma perché continuavo a non sapere cosa fare, avevo preso anch’io una sedia e mi ero messo accanto a loro, e ce ne eravamo stati là – tre figurine consunte, tre reduci non si sa da cosa e da dove: tre reietti: tre relitti; davanti a noi uno scampolo oscuro di città, qualche luce minuta, il cielo offuscato dalle nubi, la quiete».
Federica Merlo
ChiudiLeggi la recensione