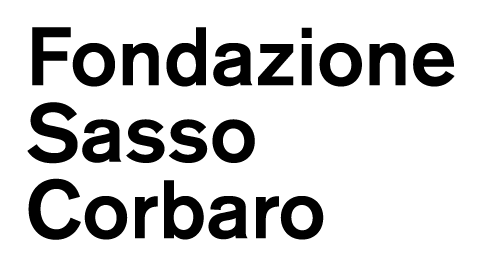Scrivere per curare, scrivere per curarsi
Uno scorcio sull’opera di quegli autori che hanno scelto di affrontare il tema della cura all’interno delle loro opere: sondando le tante facce che la malattia può assumere, riflettendo su cosa significhi prendersi cura di qualcuno, oppure – e, forse, soprattutto – facendo della scrittura uno strumento privilegiato per la cura di se stessi e del resto del mondo.
 In dueMario Luzi
In dueMario Luzi«Aiutami» e si copre con le mani il viso
tirato, roso da una gelosia senile,
che non muove a pietà come vorrebbe ma a sgomento e a orrore.
«Solo tu puoi farlo» insistono di là da quello schermo
le sue labbra dure
e secche, compresse dalle palme, farfugliando.
Non trovo risposta, la guardo
offeso dalla mia freddezza vibrare a tratti
dai gomiti puntati sui ginocchi alla nuca scialba.
«L’amore snaturato, l’amore infedele al suo principio»
rifletto, e aduno le potenze della mente
in un punto solo tra desiderio e ricordo
e penso non a lei
ma al viaggio con lei tra cielo e terra
per una strada d’altipiano che taglia
la coltre d’erba brucata da pochi armenti.
«Vedi, non trovi in fondo a te una parola»
gemono quelle labbra tormentose
schiacciate contro i denti, mentre taccio
e cerco sopra la sua testa la centina di fuoco dei monti.
Lei aspetta e intanto non sfugge alle sue antenne
quanto le sia lontano in questo momento
che m’apre le sue piaghe e io la desidero e la penso
com’era in altri tempi, in altri versanti.
«Perché difendere un amore distorto dal suo fine,
quando non è più crescita
né moltiplicazione gioiosa d’ogni bene,
ma limite possessivo e basta» vorrei chiedere
ma non a lei che ora dietro le sue mani piange scossa da un brivido,
a me che forse indulgo alla menzogna per viltà o per comodo.
«Anche questo è amore, quando avrai imparato a ravvisarlo
in questa specie dimessa,
in questo aspetto avvilito» mi rispondono, e un poco ne ho paura
e un po’ vergogna, quelle mani ossute
e tese da cui scende qualche lacrima tra dito e dito spicciando.Commento
“In due”. Io e te, ma non noi – in due, appunto, e non insieme.
Un titolo emblematico, che sembra sancire la rottura irreversibile avvenuta fra i protagonisti, ci introduce a una delle liriche che hanno segnato un punto di svolta nella carriera del poeta fiorentino Mario Luzi (1914 – 2005).Il secondo dopoguerra rappresenta, infatti, una tappa cruciale nella parabola di un autore noto, fino ad allora, per la sua vicinanza alla corrente ermetica, per la sua dedizione ad una poesia ardua, tesa, ‘simbolica’. Entro un contesto storico e sociale ormai drasticamente mutato, Luzi sente, infatti, per la prima volta la necessità di aprirsi al ‘reale’, abbandonando la privilegiata ‘separatezza’ garantita al poeta nella stagione ermetica; e, spinto dal desiderio di confrontarsi con il mondo, di attraversare la «terra desolata» in cui si consumano le vicende degli uomini, sceglie di spogliarsi del linguaggio lirico rarefatto e criptico delle precedenti raccolte per adottare forme espressive più vicine alla prosa. La più alta testimonianza di questo percorso è la raccolta “Nel Magma”, da cui è tratta la lirica su cui ci soffermeremo, “In due”: l’esile silloge, edita da Scheiwiller nel 1963 (e ristampata tre anni dopo, in edizione accresciuta, da Garzanti), raccoglie una serie di testi in cui il discorso poetico tende ad assumere la forma del dialogo e la voce dell’io a confondersi e mescolarsi a quella dei personaggi che popolano le vicende narrate.
E proprio da un’intensa, quasi lacerante, tensione dialogica sembra, infatti, prendere le mosse “In due”: un ‘nudo’ e disperato grido d’aiuto squarcia il primo verso, proiettando il lettore ‘nel magma del reale’, all’interno di una vicenda in fieri, che sembra quasi aver preso avvio ‘fuori scena’, prima dell’attacco della poesia. Quest’affranta richiesta di conforto, veicolata da una battuta di discorso diretto che rende ancor più palpabile la dimensione teatrale della poesia, inaugura una lirica tutta giocata sull’opposizione fra le percezioni, i gesti e le emozioni sperimentate dai due protagonisti: da un lato, una figura femminile rosa da «una gelosia senile», straziata dall’angoscia e protesa in un’incalzante – e quasi ‘tangibile’, nella sua fisicità – richiesta di soccorso; dall’altro, un io-lirico quasi evanescente, pietrificato, nella sua incapacità di agire; una figura presente-assente, distaccata, priva di empatia verso la donna che soffre (che, invece di compassione e «pietà», suscita in lui «sgomento» e «orrore»); un uomo irrimediabilmente «lontano», perso nei meandri del «ricordo», della riflessione, dell’immaginazione.
Quest’insanabile contrapposizione fra due poli opposti si misura, nella prima parte della poesia, nella natura stessa di un dialogo che appare sin da subito mozzato, interrotto. La tensione comunicativa che caratterizza il personaggio femminile, veicolata da tre battute espressamente – e quasi insistentemente – rivolte al tu («ascoltami», «solo tu puoi farlo», «vedi, non trovi in fondo a te una parola»), si oppone a quelle che solo in apparenza sono delle risposte: le porzioni di discorso diretto affidate al suo interlocutore non sono, infatti, altro che una serie di riflessioni silenziose e astratte, un desiderio di dire, di chiedere, di fare, che rimane sospeso, senza riuscire a concretizzarsi. All’assordante grido d’aiuto della donna risponde, quindi, il silenzio, l’assoluta incapacità di trovare «una parola» che possa placarlo. Ma c’è di più: se le riflessioni espresse dalla figura maschile sono riconducibili a un io-lirico che prende esplicitamente la parola (anche se solo nella sua mente), la sorgente del discorso della donna sembra essere sottratta all’occhio del lettore: l’obbiettivo si concentra, infatti, esclusivamente sulle parti del suo corpo della donna più straziate dalla sofferenza e, soprattutto, più segnate dalla vecchiaia, dal trascorrere impietoso del tempo. Dettagli su cui l’occhio dell’io non può fare a meno di indugiare, senza sperimentare la pietosa partecipazione che questi vorrebbero, ma, al contrario, lasciandosi cogliere dallo «sgomento» e dalla nostalgia per ciò che era in «altri tempi». A parlare, lungo l’arco di tutta la poesia, non è, infatti, la donna nella sua interezza, ma le sue «mani ossute», le sue «labbra dure e secche», «labbra tormentose / schiacciate contro i denti».
Il linguaggio del corpo delinea, poi, un ulteriore grado opposizione fra i due protagonisti: la gestualità della donna, costruita all’insegna del movimento incalzante, dei singhiozzi, del tremito che la scuote «dai gomiti» fino «alla nuca scialba» e del desiderio di nascondere i segni della sofferenza agli occhi dell’amato, coprendosi «con le mani il viso» (azioni, queste, reiterate a più riprese nell’arco di pochi versi, a sottolinearne il valore drammatico) si oppone all’immobilità dell’io-poetico, testimoniata implicitamente dal tessuto verbale che lo accompagna: «
Commento
“In due”. Io e te, ma non noi – in due, appunto, e non insieme.
Un titolo emblematico, che sembra sancire la rottura irreversibile avvenuta fra i protagonisti, ci introduce a una delle liriche che hanno segnato un punto di svolta nella carriera del poeta fiorentino Mario Luzi (1914 – 2005).Il secondo dopoguerra rappresenta, infatti, una tappa cruciale nella parabola di un autore noto, fino ad allora, per la sua vicinanza alla corrente ermetica, per la sua dedizione ad una poesia ardua, tesa, ‘simbolica’. Entro un contesto storico e sociale ormai drasticamente mutato, Luzi sente, infatti, per la prima volta la necessità di aprirsi al ‘reale’, abbandonando la privilegiata ‘separatezza’ garantita al poeta nella stagione ermetica; e, spinto dal desiderio di confrontarsi con il mondo, di attraversare la «terra desolata» in cui si consumano le vicende degli uomini, sceglie di spogliarsi del linguaggio lirico rarefatto e criptico delle precedenti raccolte per adottare forme espressive più vicine alla prosa. La più alta testimonianza di questo percorso è la raccolta “Nel Magma”, da cui è tratta la lirica su cui ci soffermeremo, “In due”: l’esile silloge, edita da Scheiwiller nel 1963 (e ristampata tre anni dopo, in edizione accresciuta, da Garzanti), raccoglie una serie di testi in cui il discorso poetico tende ad assumere la forma del dialogo e la voce dell’io a confondersi e mescolarsi a quella dei personaggi che popolano le vicende narrate.
E proprio da un’intensa, quasi lacerante, tensione dialogica sembra, infatti, prendere le mosse “In due”: un ‘nudo’ e disperato grido d’aiuto squarcia il primo verso, proiettando il lettore ‘nel magma del reale’, all’interno di una vicenda in fieri, che sembra quasi aver preso avvio ‘fuori scena’, prima dell’attacco della poesia. Quest’affranta richiesta di conforto, veicolata da una battuta di discorso diretto che rende ancor più palpabile la dimensione teatrale della poesia, inaugura una lirica tutta giocata sull’opposizione fra le percezioni, i gesti e le emozioni sperimentate dai due protagonisti: da un lato, una figura femminile rosa da «una gelosia senile», straziata dall’angoscia e protesa in un’incalzante – e quasi ‘tangibile’, nella sua fisicità – richiesta di soccorso; dall’altro, un io-lirico quasi evanescente, pietrificato, nella sua incapacità di agire; una figura presente-assente, distaccata, priva di empatia verso la donna che soffre (che, invece di compassione e «pietà», suscita in lui «sgomento» e «orrore»); un uomo irrimediabilmente «lontano», perso nei meandri del «ricordo», della riflessione, dell’immaginazione.
Quest’insanabile contrapposizione fra due poli opposti si misura, nella prima parte della poesia, nella natura stessa di un dialogo che appare sin da subito mozzato, interrotto. La tensione comunicativa che caratterizza il personaggio femminile, veicolata da tre battute espressamente – e quasi insistentemente – rivolte al tu («ascoltami», «solo tu puoi farlo», «vedi, non trovi in fondo a te una parola»), si oppone a quelle che solo in apparenza sono delle risposte: le porzioni di discorso diretto affidate al suo interlocutore non sono, infatti, altro che una serie di riflessioni silenziose e astratte, un desiderio di dire, di chiedere, di fare, che rimane sospeso, senza riuscire a concretizzarsi. All’assordante grido d’aiuto della donna risponde, quindi, il silenzio, l’assoluta incapacità di trovare «una parola» che possa placarlo. Ma c’è di più: se le riflessioni espresse dalla figura maschile sono riconducibili a un io-lirico che prende esplicitamente la parola (anche se solo nella sua mente), la sorgente del discorso della donna sembra essere sottratta all’occhio del lettore: l’obbiettivo si concentra, infatti, esclusivamente sulle parti del suo corpo della donna più straziate dalla sofferenza e, soprattutto, più segnate dalla vecchiaia, dal trascorrere impietoso del tempo. Dettagli su cui l’occhio dell’io non può fare a meno di indugiare, senza sperimentare la pietosa partecipazione che questi vorrebbero, ma, al contrario, lasciandosi cogliere dallo «sgomento» e dalla nostalgia per ciò che era in «altri tempi». A parlare, lungo l’arco di tutta la poesia, non è, infatti, la donna nella sua interezza, ma le sue «mani ossute», le sue «labbra dure e secche», «labbra tormentose / schiacciate contro i denti».
Il linguaggio del corpo delinea, poi, un ulteriore grado opposizione fra i due protagonisti: la gestualità della donna, costruita all’insegna del movimento incalzante, dei singhiozzi, del tremito che la scuote «dai gomiti» fino «alla nuca scialba» e del desiderio di nascondere i segni della sofferenza agli occhi dell’amato, coprendosi «con le mani il viso» (azioni, queste, reiterate a più riprese nell’arco di pochi versi, a sottolinearne il valore drammatico) si oppone all’immobilità dell’io-poetico, testimoniata implicitamente dal tessuto verbale che lo accompagna: «non trovo risposta», «guardo», «rifletto», «penso», «taccio». Un soggetto che consapevolmente – e colpevolmente – si rifugia negli spazi elusivi della memoria, si perde nel ricordo dei viaggi «tra cielo e terra» compiuti in stagioni passate, in «altri versanti», quando l’aspetto della compagna non era ancora segnato dall’inesorabile scorrere del tempo. Quelle dell’io-lirico non sono, tuttavia, le fantasticherie ciniche di un individuo cieco di fronte alla propria crudele «freddezza», ma, al contrario, sembrano essere il prodotto di un impulso irrefrenabile che «offende» in primo luogo chi lo sperimenta e, in qualche modo, ne è vittima – donde, nel finale, l’ammissione del proprio indulgere nella menzogna, del proprio essere ‘bloccati’, per vigliaccheria o per comodità, in un amore ormai «distorto dal suo fine».
Questa concezione dell’amore è, forse, la sintesi ultima del tormentato rapporto fra i protagonisti di “In due”. Se per tre quarti della lirica alla supplica della donna (che chiede di essere amata da colui che le aveva promesso amore eterno, da quell’unico uomo che ha la possibilità – «solo tu puoi farlo» – e, implicitamente, quindi, il dovere di amarla) si contrappone il freddo, asettico filosofeggiare della figura maschile (che descrive un amore in balia all’azione devastante del tempo, un sentimento che, confrontato con l’erosione dei corpi, non è altro che «limite possessivo», pallida imitazione di ciò che era «al suo principio»), la chiusa della poesia segna uno stacco e un’apertura verso una – seppur fragile – possibilità di riscatto. Dalle mani ossute della donna, ormai non più scosse dal tumulto dei singhiozzi ma appena rigate «da qualche lacrima» che cola silenziosa «tra dito e dito», sgorga una pacata, lucida constatazione: «anche questo è amore», anche questo sentimento così diverso dall’effervescenza di un tempo, dalla «crescita» e dalla «moltiplicazione gioiosa di ogni bene» che inebriava una volta, è comunque amore. Occorre solo imparare a riconoscerlo in questo suo aspetto nuovo, dimesso, mutato. Un’affermazione, questa, che produce nell’io «un poco» di «paura» e di «vergogna» (paura che la donna abbia ragione, vergogna di non aver saputo giungere autonomamente a questa conclusione, forse?): sentimenti dimessi, intimi, vissuti ‘sottovoce’ – infinitamente lontani dallo «sgomento» e dall’«orrore» che prorompevano nell’incipit.
Questo barlume di speranza, questa precaria apertura verso una possibilità di comunicazione, in una lirica che altrimenti appariva quasi interamente siglata dall’incomunicabilità, non sembra alterare, tuttavia, il carattere amaro di un discorso poetico che pare nato non dal desiderio di scrivere per curare, o di scrivere per curarsi – come vorrebbe il titolo di questa rubrica – ma dall’impulso opposto: nella composizione di “In due” Mario Luzi sembra infatti essere mosso dalla necessità di denunciare la propria assoluta incapacità di prendersi cura. Il poeta sembra infatti incapace di prendersi cura della donna amata, di rispondere alla sua richiesta d’aiuto, di accettarla anche nella sua vecchiaia, provando pietà e affetto e non ribrezzo di fronte alla sofferenza altrui. Inoltre, appare del tutto incapace di prendersi cura del loro amore, paralizzato da un’inerzia che gli impedisce sia di troncare il rapporto, confidando alla donna le proprie incertezze, sia di comprendere e accettare la sua natura mutata. E, non da ultimo, Mario Luzi sembra non essere in grado di prendersi cura neppure di sé stesso, di curare la propria aridità interiore, limitandosi a denunciare impietosamente la propria mancanza d’amore, la propria inadeguatezza al mondo.
«[In “In due”] è in primo piano la mancanza di carità, l’incapacità di ascoltare e di capire dell’osservatore-poeta, denunciata dalla ripugnanza ostentata nei confronti di chi soffre, dai silenzi colpevoli, dal ricorso strumentale ai lenimenti della memoria o delle divagazioni, e, soprattutto, della “crudeltà” dello sguardo, della “cattiveria rappresentativa” esercitata sugli altri, ma solo per fare definitivamente i conti con se stessi, con le proprie insufficienze e le proprie tare». (G. Fontana, Disconoscimenti. Appunti su “Nel Magma” di Mario Luzi., Nuova Corrente, a. 54 [2007], n. 140, pp. 257-282).
Valentina Fontana
Newsletter #15, Aprile 2021Continua a leggereChiudi Tènere cresciteAmelia Rosselli
Tènere cresciteAmelia RosselliTènere crescite mentre l’alba s’appressa tènere crescite
di questa ansia e angoscia che non può amare né sé né
coloro che facendomi esistere mi distruggono. Tenerissima
la castrata notte quando dai singulti dell’incrociarsi
della piazza con strada sento stridori ineccepibili,
le strafottenti risa di giovinotti che ancora vivere
sanno se temere è morire. Nulla può distrarre il giovane
occhio da tanta disturbanza, tante strade a vuoto, le
case sono risacche per le risate. Mi ridono ora che le
imposte con solenne gesto rimpalmano altre angosce
di uomini ancor più piccoli e se consolandomi d’esser
ancora tra i vivi un credere, rivedevo la tua gialla faccia
tesa, quella del quasi genio – è per sentire in tutto
il peso della noia il disturbarsi per così poco.Amelia Rosselli, da Serie Ospedaliera, 1969
Commento
Il fluire pressoché ininterrotto del discorso poetico in Ténere crescite di Amelia Rosselli (1930-1996), lirica in cui ogni verso – complici le forti inarcature – ‘trabocca’ nel successivo, sembra rifuggire da qualsiasi tipo di ingabbiamento grammaticale, sintattico o dettato dalla semplice punteggiatura. Eppure, osservando con attenzione, si nota come quest’apparente disordine e questa tendenza ‘anarchica’ si producano all’interno di una cornice metrica ben precisa: la «forma cubo» – come la definisce la stessa Rosselli – una particolare struttura, ideata dall’autrice, che, basandosi sul ritmo della battuta musicale, fa sì che la lunghezza del primo verso detti la lunghezza e il numero dei successivi, dando così alla poesia un aspetto simile a quello un quadrato, o a quello di un cubo, appunto. La tragicità delle vicende narrate e il travaglio interiore vissuto dall’‘io lirico’ – in questa come nella maggior parte delle composizioni di Amelia Rosselli – sembrano quindi ‘contenuti’, e in qualche maniera mitigati, da una griglia formale governata da leggi matematiche e musicali.
La musicologia è, infatti, la disciplina in cui si forma una delle poche donne ad essere entrate nel ‘canone’ del Novecento letterario italiano, l’unica poetessa accolta da Pier Vincenzo Mengaldo nella prestigiosa antologia “Poeti Italiani del Novecento”. Nonostante questo precoce riconoscimento, la vicenda letteraria di Amelia Rosselli non è priva di ostacoli, proprio come la sua parabola esistenziale: se da un lato la complessità dei suoi testi e la particolarità di uno stile decisamente poco imitabile le hanno costato, almeno fino a qualche anno fa, un giudizio sommario da parte della critica (che ha etichettato la sua opera come un semplice, seppur interessante, prodotto del suo disturbo psichico), dall’altro la condizione di eterna esiliata (nata a Parigi e poi emigrata in Inghilterra e in America, prima di fare ritorno in Italia), i tanti lutti che l’hanno colpita nel corso degli anni e la difficoltà a inserirsi in un contesto storico nel quale si è da sempre sentita estranea, hanno segnato profondamente la sua vita, fino a condurla al suicidio nel 1996. Nel corso degli anni ’60, poco dopo il suo esordio letterario, in un periodo in cui entra ed esce dagli istituti psichiatrici, Amelia Rosselli scrive i testi che comporranno, qualche anno più tardi, la raccolta Serie Ospedaliera (1969): una serie di liriche – fra le quali anche Tènere crescite – che danno voce alla guerra interiore vissuta dall’autrice, e riflettono sulla condizione del malato rinchiuso di un ospedale.
Proprio in questo contesto, nell’atmosfera rarefatta di una stanza situata all’interno di una struttura psichiatrica, si colloca la breve ma intensa narrazione che è al centro della nostra lirica. Nel torpore dell’alba che si avvicina, nel tempo sospeso che segna il passaggio fra notte e giorno, il racconto di un ‘io lirico’ (identificabile con la stessa poetessa) si articola su uno spazio doppio, giocato sull’opposizione fra interni ed esterni: dentro e fuori l’ospedale, dentro e fuori la malattia, dentro e fuori la propria interiorità – che è, in ultima istanza, l’unico vero ‘luogo’ di questa poesia, tutta concentrata sulle percezioni di un soggetto che si strugge senza possibilità di comunicare, senza riuscire ad interagire con gli altri ‘personaggi’ che popolano la vicenda. Accanto alla prima persona si intravvede infatti fra i versi una serie di ‘loro’: dei «giovinotti strafottenti», intenti a muoversi da un lato all’altro di una piazza, ridendo alla vita impavidi (perché «temere è morire»); e dei medici e degli infermieri che si affaccendano attorno alla poetessa, adoperandosi per «farla esistere», per tenerla in vita, senza capire che questo produce in lei l’effetto opposto – le loro attenzioni la «distruggono», abbandonandola all’«ansia e angoscia» che non le consentono di amare neppure sé stessa.
Un equivoco, questo, che sancisce l’impossibilità dell’‘io lirico’ di comunicare con l’esterno: se con i «giovinotti» qualsiasi possibilità di dialogo sembra preclusa dalla loro irrimediabile lontananza (sono lontani sul piano spaziale, dalla sua camera d’ospedale, ma anche, e soprattutto, sono lontani sul piano ideale, perché immersi una condizione di serenità spensierata aliena a quella della poetessa, che non può fare altro che ascoltarli e osservarli da una posizione distaccata), con i curanti la comunicazione risulta addirittura spezzata, interrotta, impossibile. Medici e infermieri – riassunti icasticamente nella «gialla faccia / tesa» degli ultimi versi – appaiono infatti completamente incapaci di mettersi in sintonia con il mondo interiore dell’ammalata – incapaci di capire che curandola, facendo quello che credono il suo bene (o forse solo applicando meccanicamente protocolli ospedalieri), le arrecano un danno. Chiudendo le imposte della finestra da cui filtrano le risate dei «giovinotti» e si intravvedono i loro movimenti – una «disturbanza» da cui il «giovane occhio» della poetessa non riesce a staccarsi, ammaliato e irretito da quell’unica consolazione «d’esser /
Commento
Il fluire pressoché ininterrotto del discorso poetico in Ténere crescite di Amelia Rosselli (1930-1996), lirica in cui ogni verso – complici le forti inarcature – ‘trabocca’ nel successivo, sembra rifuggire da qualsiasi tipo di ingabbiamento grammaticale, sintattico o dettato dalla semplice punteggiatura. Eppure, osservando con attenzione, si nota come quest’apparente disordine e questa tendenza ‘anarchica’ si producano all’interno di una cornice metrica ben precisa: la «forma cubo» – come la definisce la stessa Rosselli – una particolare struttura, ideata dall’autrice, che, basandosi sul ritmo della battuta musicale, fa sì che la lunghezza del primo verso detti la lunghezza e il numero dei successivi, dando così alla poesia un aspetto simile a quello un quadrato, o a quello di un cubo, appunto. La tragicità delle vicende narrate e il travaglio interiore vissuto dall’‘io lirico’ – in questa come nella maggior parte delle composizioni di Amelia Rosselli – sembrano quindi ‘contenuti’, e in qualche maniera mitigati, da una griglia formale governata da leggi matematiche e musicali.
La musicologia è, infatti, la disciplina in cui si forma una delle poche donne ad essere entrate nel ‘canone’ del Novecento letterario italiano, l’unica poetessa accolta da Pier Vincenzo Mengaldo nella prestigiosa antologia “Poeti Italiani del Novecento”. Nonostante questo precoce riconoscimento, la vicenda letteraria di Amelia Rosselli non è priva di ostacoli, proprio come la sua parabola esistenziale: se da un lato la complessità dei suoi testi e la particolarità di uno stile decisamente poco imitabile le hanno costato, almeno fino a qualche anno fa, un giudizio sommario da parte della critica (che ha etichettato la sua opera come un semplice, seppur interessante, prodotto del suo disturbo psichico), dall’altro la condizione di eterna esiliata (nata a Parigi e poi emigrata in Inghilterra e in America, prima di fare ritorno in Italia), i tanti lutti che l’hanno colpita nel corso degli anni e la difficoltà a inserirsi in un contesto storico nel quale si è da sempre sentita estranea, hanno segnato profondamente la sua vita, fino a condurla al suicidio nel 1996. Nel corso degli anni ’60, poco dopo il suo esordio letterario, in un periodo in cui entra ed esce dagli istituti psichiatrici, Amelia Rosselli scrive i testi che comporranno, qualche anno più tardi, la raccolta Serie Ospedaliera (1969): una serie di liriche – fra le quali anche Tènere crescite – che danno voce alla guerra interiore vissuta dall’autrice, e riflettono sulla condizione del malato rinchiuso di un ospedale.
Proprio in questo contesto, nell’atmosfera rarefatta di una stanza situata all’interno di una struttura psichiatrica, si colloca la breve ma intensa narrazione che è al centro della nostra lirica. Nel torpore dell’alba che si avvicina, nel tempo sospeso che segna il passaggio fra notte e giorno, il racconto di un ‘io lirico’ (identificabile con la stessa poetessa) si articola su uno spazio doppio, giocato sull’opposizione fra interni ed esterni: dentro e fuori l’ospedale, dentro e fuori la malattia, dentro e fuori la propria interiorità – che è, in ultima istanza, l’unico vero ‘luogo’ di questa poesia, tutta concentrata sulle percezioni di un soggetto che si strugge senza possibilità di comunicare, senza riuscire ad interagire con gli altri ‘personaggi’ che popolano la vicenda. Accanto alla prima persona si intravvede infatti fra i versi una serie di ‘loro’: dei «giovinotti strafottenti», intenti a muoversi da un lato all’altro di una piazza, ridendo alla vita impavidi (perché «temere è morire»); e dei medici e degli infermieri che si affaccendano attorno alla poetessa, adoperandosi per «farla esistere», per tenerla in vita, senza capire che questo produce in lei l’effetto opposto – le loro attenzioni la «distruggono», abbandonandola all’«ansia e angoscia» che non le consentono di amare neppure sé stessa.
Un equivoco, questo, che sancisce l’impossibilità dell’‘io lirico’ di comunicare con l’esterno: se con i «giovinotti» qualsiasi possibilità di dialogo sembra preclusa dalla loro irrimediabile lontananza (sono lontani sul piano spaziale, dalla sua camera d’ospedale, ma anche, e soprattutto, sono lontani sul piano ideale, perché immersi una condizione di serenità spensierata aliena a quella della poetessa, che non può fare altro che ascoltarli e osservarli da una posizione distaccata), con i curanti la comunicazione risulta addirittura spezzata, interrotta, impossibile. Medici e infermieri – riassunti icasticamente nella «gialla faccia / tesa» degli ultimi versi – appaiono infatti completamente incapaci di mettersi in sintonia con il mondo interiore dell’ammalata – incapaci di capire che curandola, facendo quello che credono il suo bene (o forse solo applicando meccanicamente protocolli ospedalieri), le arrecano un danno. Chiudendo le imposte della finestra da cui filtrano le risate dei «giovinotti» e si intravvedono i loro movimenti – una «disturbanza» da cui il «giovane occhio» della poetessa non riesce a staccarsi, ammaliato e irretito da quell’unica consolazione «d’esser / ancora qui tra i vivi» – per paura che possa turbare l’ammalata, le inibiscono in realtà l’accesso all’unico barlume di vita, di fiducia nell’esistenza. Parallelamente, l’‘io lirico’ non sembra essere in grado di esternare questo disagio, di protestare contro queste premure indesiderate, di comunicare il proprio male: l’unica reazione che ne sussegue, infatti, è un freddo, disincantato sprofondamento dietro al muro della noia, dell’autoannullamento, dell’apatia.
Il tema dell’incomunicabilità – cifra di gran parte della produzione poetica dell’autrice, la cui scrittura spesso nasce proprio da un’esigenza comunicativa – si associa al profondo senso di disappartenenza vissuto dall’‘io lirico’: disappartenenza dal contesto esterno, che gli è precluso, ma disappartenenza anche rispetto al mondo interno dell’ospedale, che non è in grado di comprenderlo. In sintesi: una scissione profonda e insanabile dal resto del mondo. Per Amelia Rosselli la poesia diventa quindi un modo per affrontare questa scissione, uno strumento per ritrovare una forma di comunicazione, per avvicinare un mondo estraneo e mitigare, chiudendolo e ‘oggettivandolo’ nel «cubo» delle sue poesie, un dolore altrimenti indicibile.
Figura complessa, tormentata e difficilmente penetrabile (come la densità di questa lirica testimonia) e, insieme, profondamente affascinante, Amelia Rosselli rappresenta indubbiamente una delle voci più emblematiche della poesia femminile Novecentesca, e una delle scrittrici che, attingendo al proprio vissuto, ha saputo fare della scrittura un prezioso e indispensabile strumento di cura. Non credo ci siano parole migliori, per concludere questo breve excursus su Amelia Rosselli, di quelle impiegate da chi la conobbe personalmente. Emanuele Trevi – scrittore e critico letterario – citando passi della “Storia di una malattia” (Nuovi Argomenti, n. 56, 1977), in cui la stessa Rosselli riflette lucidamente sulla propria condizione, ne traccia un ritratto straziante e insieme profondamente poetico, del tutto coerente con l’essenza della poesia che abbiamo analizzato, descrivendo i brevi ma intensi momenti di consolazione, nei quali – per sfuggire al male che l’attanaglia – attraversa in motorino il reticolo delle strade di Roma:
Quando voleva evitare un eccesso di «onde magnetiche» Amelia Rosselli usciva in motorino. Idea tutt’altro che stupida: l’agilità e la rapidità dei movimenti premessa da un mezzo simile «rendevano difficile» – così si legge nella “Storia di una malattia” – la localizzazione. Era più un palliativo che una soluzione. «I commenti di ordine ossessivo-ironico», infatti, «si susseguivano anche durante la guida e rendevano la marcia un poco pericolosa». Sulla mappa secolare della città, gli itinerari di queste corse in motorino tracciano curve e rettilinei che fanno pensare a un’arcana sapienza, come i gesti e le percezioni minuziose di un rito vedico. La marcia pericolosa produce una figura, il perimetro di un bastione opposto all’avanzare di forze malvage, onnipotenti. Non è una fuga, ma una storia. Solo un angelo di passaggio nel cielo di Roma sarebbe stato in grado di apprezzarla, osservandola dall’alto. Avrebbe sicuramente meditato, l’angelo, sulla disperata bellezza degli esseri umani e delle loro guerre.
(Emanuele Trevi, Sogni e favole. Un apprendistato, Ponte alle Grazie, 2018).Valentina Fontana
Febbraio 2021, Newsletter #13Continua a leggereChiudi